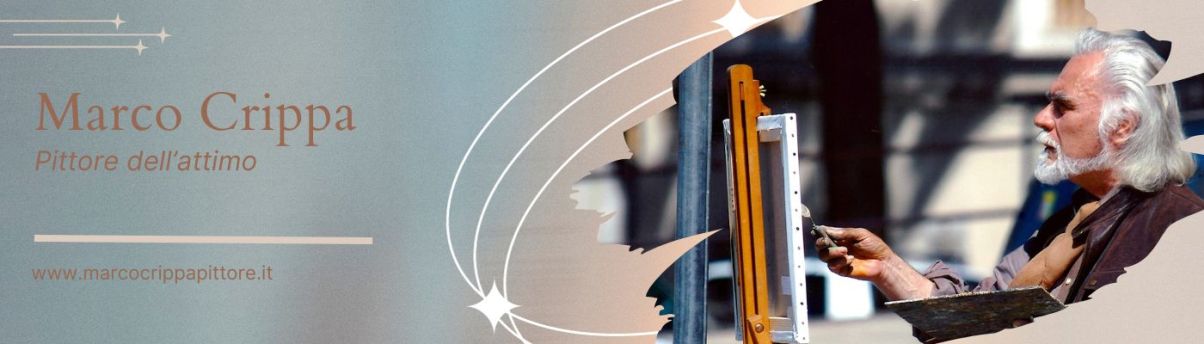Marco Crippa - il pittore della strada
A CURA DI MIMMO DI MARZIO
«Era una delle tante giornate grigie di Milano, però senza la pioggia, con quel cielo incomprensibile che non si capiva se fossero nubi o soltanto nebbia al di là della quale il sole, forse. Oppure semplicemente caligine uscita dai camini, dagli sfiatatoi delle caldaie a nafta, dalle ciminiere delle raffinerie Coloradi, dai camion ruggenti, dalle fogne, dai cumuli di detriti immondi rovesciati sulle aree fabbricabili della periferia, dalla trachea dei milioni e milioni – erano tanti? – assembrati fra cemento, asfalto e rabbia intorno a lui». Così, nelle pagine di Un amore, pubblicato nel ’63, Dino Buzzati descriveva la sua città di adozione, quella Milano amata e anche un po’ odiata dallo scrittore-artista per quel suo essere «torbida e licenziosa con una sottile ironia che sfocia spesso in cinismo». Buzzati la descriveva spesso, nelle storie letterarie e pittoriche da lui ambientate e reinventate oniricamente quasi sempre nel perimetro della quotidianità; da Porta Venezia a via San Vittore, teatro dei racconti giornalistici racchiusi nella raccolta La Nera; alla stessa via Solferino, sede storica del Corsera (dove oggi gli hanno dedicato una sala, mentre allora – sic – i colleghi gli davano del «cretinetti»...); e ancora la Brera di corso Garibaldi ai numeri 72 e 73, dove oggi troviamo un passaggio sormontato da un arco, e dove i protagonisti di «Un amore» vivevano intensamente una città fatta di case ravvicinate, quasi addossate fra cumuli e tetti. Era questa, appunto, la Milano di Buzzati, una città fatta di scorci immortalati nelle sue opere, prosaica e al contempo onirica, nostalgica e struggente nella sua anima popolare piena di vivacità e mistero.
É la stessa anima popolare che trasuda dai paesaggi
urbani di Marco Crippa il quale, a differenza di
Buzzati che era bellunese, a Milano è nato e
cresciuto tra le case di ringhiera del rione Isola,
quando quest’ultimo non era un quartiere di notti
glamour e boschi verticali, ma una zona povera «dove
le famiglie si aiutavano passandosi i vestiti usati
e la minestra dai balconi». Era la Milano del
Miracolo cinematografico di De Sica, del Fabbricone
di Gianni Testori e dello Spazzacamino del
cantastorie Nanni Svampa. Nell’immediato dopoguerra
Crippa frequenta l’Accademia di Brera, che in quegli
anni vanta docenti del calibro di
Achille Funi, Aldo Carpi, Gianfranco Campestrini.
Erano gli anni in cui l’Accademia, ma soprattutto il
quartiere su cui gravitava, si apprestava a
diventare l’epicentro di tendenze e avanguardie
artistiche che avrebbero di lì a poco eletto Milano
a capitale dell’arte contemporanea. Ma l’Accademia,
sia dentro che fuori, sia prima che dopo, si era già
rivelata un perimetro troppo stretto per un artista
che aveva scelto la strada come propria musa e
compagna di vita. Tanto il suo amore per l’arte (sul
braccio si fece tatuare una tavolozza firmata con la
dichiarazione: “più arte che amore” quanto quello
per la strada, traggono origini dall’humus
familiare. Durante la guerra - racconta il figlio
Davide, depositario di un affascinante archivio di
storie – “Il nonno si rifiutò di sfollare e mio
padre guarderà dal ponte di Garibaldi, con i suoi
quattro fratelli, le bombe che cadono su Milano. Era
una casa dove si parlava soltanto il dialetto
milanese, e dove la sera, il nonno, che aveva
l’hobby per la pittura, la sera metteva i cinque
figli attorno al tavolo per farli disegnare”. Da
questa abitudine nacque la sua grande passione e la
decisione di frequentare i corsi serali a Brera,
dove avrebbe conosciuto anche De Pisis che un
giorno gli disse, ancora giovanissimo: “Tu
dipingi la città come se ci fossi dentro, non
davanti”. Mica male come complimento, detto
dal grande maestro ferrarese.
Quella città, Milano, sarebbe diventata la sua
eterna e sola modella, raccontata quasi in ogni
vicolo e in ogni sua piazza con uno stile pittorico
fatto di colpi di spatola e di colori puri spremuti
direttamente dal tubetto; il suo atelier rimase per
sempre la strada, e le vedute en plein air alla
maniera degli Impressionisti. In principio fu Porta
Venezia, che era la zona dove andò a vivere in una
piccola casa studio praticamente senza cucina, in
via Paracelso. Tranne che per brevi fughe a Venezia
e a Parigi, la Milano urbana sarebbe sempre stata la
sua casa, ritratta su tele di medio formato che
completava in un giorno e vendeva al popolo
stanziale o frettoloso della strada: negozianti,
impiegati, imprenditori, turisti. Le vedute che
Crippa eseguiva con il cavalletto strategicamente
piazzato agli angoli delle piazze o nei vicoli
pedonali del centro storico catturavano i passanti
per l’istantaneità e il respiro di una pittura
abbozzata, senza l’ausilio del disegno, ma appena
tratteggiata dal colore poi steso e graffiato con le
spatole o con i manici dei pennelli.
Una tavolozza essenziale, si potrebbe dire quasi
scarna, quella di Crippa, dove il colore rappresenta
solo il pretesto per l’espressività del segno.
Eccolo vicino a un semaforo di via Galvani, a due
passi dalla Stazione Centrale, oppure mentre cattura
uno scorcio della caotica piazza Argentina, in
Loreto, o ancora tra le auto parcheggiate accanto a
un’edicola di giornali in corso Buenos Aires. Di
volta in volta, il cannocchiale urbano prende forma
veloce sulla tela, muta forza e vibrazione, a
seconda delle ore del giorno e della notte, ma anche
della temperatura e della stagione con la stessa
alchimia che in altri tempi contraddistingueva le
vedute dei grandi impressionisti come Monet o
Pissarro.
La giornata di un artista totale come Crippa non
aveva scadenze, salvo quella dei tempi di
essiccazione dei colori. Ricorda il figlio: “Mio
padre ha lavorato e vissuto in strada, non ha mai
praticato altro che la pittura, rifiutando qualsiasi
ripiego di mantenimento, o l’insegnamento, o lavori
su commissione come spesso fanno artisti anche molto
blasonati.” Il motto «più arte che amore» era uno
scotto da pagare anche per la famiglia, negli anni
in cui Crippa è diventato ormai un personaggio che
pare uscito direttamente dalla bohème della
Montmatre dei primi del Novecento: capelli lunghi
antesignani del Sessantotto, barba, pipa, vistosi
anelli alle dita e tanti gesti di altruismo e
d’impulso: “Come la sera in cui tornò a casa con una
scimmia sulle spalle, che lui aveva deciso di
adottare in famiglia”.
Marco Crippa è sempre stato un outsider, fuori dalle
regole, fuori dagli schemi e, si diceva, anche fuori
dal cosiddetto sistema dell’arte. Ciò non gli ha
impedito, nell’arco della sua lunga vita, di
ottenere stima e riconoscimenti in mostre pubbliche,
come quella dell’89 al Museo di Milano di via
Sant’Andrea, che gli fecero guadagnare anche uno
scambio forse folgorante con grandi maestri della
pittura italiana come Filippo De Pisis - da
cui in parte ha assorbito il guizzo istintivo e
Carlo Carrà. Ma furono attimi, momenti di gloria
fuggevoli che nulla aggiunsero e nulla tolsero a un
artista che ebbe, lo ripetiamo, come unica maestra
la strada, quella che il contemporaneo Giorgio
Gaber decantava come sola via di salvezza per
l’uomo: «C'è solo la strada su cui puoi contare,
la strada è l'unica salvezza, c'è solo la voglia e
il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e
nella piazza, perché il giudizio universale non
passa per le case, le case dove noi ci nascondiamo;
bisogna ritornare nella strada, nella strada, per
conoscere chi siamo».
Distante dall’intimità, dai tempi e dai ripensamenti
della pittura in studio, Crippa ha lavorato
all’aperto; si è esibito in piedi cercando spesso il
centro della scena, esponendo ai passanti la
sincerità della sua tela bianca, fuggendo dal
silenzio e dalla solitudine come da un castigo. Con
la strada, le sue sfumature, i suoi rumori di fondo,
le sue luci, le sue foschie, i suoi palazzi, i suoi
marciapiedi brulicanti di vita, con la vita e gli
odori della città e dei negozi Crippa si è
catarticamente fuso nell’atto di guardare e tradurre
sulla tela, incurante ed anche esaltato dal pubblico
che si arrestava ora per cercare un contatto ora per
seguire la sua performance in silenzio.
Nondimeno, appare oggi quasi paradossale che il
testimone di cotanta vita sia rimasto pressoché
vergine, immune e impermeabile al ciclone artistico
che dagli anni Sessanta vide Milano epicentro della
ricerca artistica internazionale. Crippa visse
appieno il decennio magico che contraddistinse il
panorama culturale e, in generale, della creatività
all’ombra della Madonnina. Negli anni Sessanta,
Milano era un mondo da scoprire, capitale italiana
assoluta dell’arte europea, in un periodo in cui
Roma produceva essenzialmente artisti nazionali che
si ispiravano alla Pop art americana. Ben diversa
era la situazione milanese, caratterizzata da una
forte animazione «scientista» aperta all’avanguardia
e che, fin dal decennio precedente, tenne a
battesimo nuovi movimenti che sarebbero entrati
nella Storia: dall’arte nucleare di Enrico Baj
allo spazialismo di Lucio Fontana, fino al
neodadaismo di Piero Manzoni.
Questo fermento, che sovvertì ogni punto di
riferimento accademico in nome di un’arte aperta
all’ambiente e allo spazio della vita, sobbolliva a
stretto contatto con la vita di una città che più di
tutte, in Italia, avvertiva l’ebbrezza derivante
dalla spinta del boom economico. Così, mentre la
collettività si educava quotidianamente alla nuova
estetica di guru del design come Franco Albini,
Bob Noorda, Bruno Munari, Marco Zanuso, Achille
Castiglioni, Vico Magistretti, Enzo Mari e molti
altri, i rivoluzionari dell’arte scuotevano la città
di plateali provocazioni. Una su tutte fu quella
portata sotto la Madonnina dal padre del Nuovo
Realismo Pierre Restany e la compagine
formata da Christo, Arman, César, Tinguely,
Dufrêne, Niki de Saint Phalle e Spoerri che - da
piazza Duomo a piazza Scala, dalla Rotonda della
Besana alla Galleria Vittorio Emanuele - sconvolsero
(ed esaltarono) la città con mostre e performance
che celebravano la fine dell’opera d’arte in nome di
un’avanguardia che denunciava l’appiattimento della
società dei consumi di massa. E la pittura? Già i
monocromi di Piero Manzoni, e poi di Yves
Klein, ne avevano pubblicamente decretato il
«grado zero»: d’ora in poi, più che l’opera, a
contare erano solo la firma e la presenza
dell’artista.
Non sappiamo se e con quale assiduità il “pittore
di strada” Marco Crippa frequentasse i tavolini
del bar Jamaica, il quartier generale degli
avanguardisti europei a Milano. Ignoriamo se egli
abbia presenziato o fosse stato a conoscenza della
mostra del maggio 1960 alla galleria “Apollinaire”
di Guido Le Noci in via Brera 4, dove Restany
presentò il Manifesto dei Nouveaux Realistes, la
stessa galleria dove tre anni prima Yves Klein aveva
presentato per la prima volta Proposte monocrome -
epoca blu. Non sappiamo se Crippa, che nelle sue
scorribande privilegiava le zone del centro storico,
abbia assistito tra il 26 e il 27 novembre
all’impacchettamento da parte di Christo della
statua di Vittorio Emanuele in piazza Duomo; non
sappiamo se fosse presente sotto la volta della
Galleria Vittorio Emanuele quando Cèsar distribuì ai
cittadini pezzi della sua Espansione in poliuretano
espanso; se si fosse meravigliato e divertito
davanti allo svelamento in piazza Duomo della
«Vittoria» di Jean Tinguely, un gigantesco fallo
dorato che esplose nel cielo notturno di Milano tra
fuochi di artificio, fumo e scintille,
autodistruggendosi in meno di tre quarti d’ora. E
ancora, non sappiamo se, come tanti milanesi, due
giorni dopo si fosse stupito davanti alle esibizioni
di Niki de Saint Phalle, quando allestì un
paradossale altare come bersaglio per i suoi tiri di
carabina che fecero colare il colore su cristi e
madonne. Non sappiamo insomma se il pittore di
strada partecipò sia pure tangenzialmente al
fermento culturale che caratterizzò quei
rivoluzionari anni Sessanta che, come era avvenuto
durante il Futurismo, avevano reso Milano il
laboratorio europeo della modernità; un decennio
irripetibile anche per la musica, con l’approdo
sotto la Madonnina dei big d’oltreoceano (memorabili
i concerti di Billie Holiday al Teatro
Smeraldo e dei Rolling Stones al Palalido),
un grande sogno che si interruppe violentemente il
12 dicembre del 1969 con l’attentato di piazza
Fontana che aprì la stagione del terrore.
Ignoriamo, ma possiamo a buon diritto immaginare che
in quei giorni febbrili Crippa fosse in piedi
davanti al suo cavalletto, in qualche modo anche lui
imbevuto di una energia nuova - foulard al collo e
sigaretta all’angolo della bocca - immerso a
interpretare con spatole e colori gli incroci della
città, quei suoi abitanti mai coi man in man intenti
a rincorrere le faccende quotidiane, così come i
turisti comodamente seduti ai tavolini dei caffè di
Brera. Di sicuro, Brera era una delle sue tappe,
come ben testimonia il ciclo di vedute en plein air
via Brera angolo via Pontaccio, via Fiori Chiari, o
via Verdi angolo via dell’Orso, quasi un mosaico di
affreschi sull’energia vitale del quartiere caro
agli artisti. Più che dai simboli monumentali della
città, il «pittore della strada» era attratto
dall’anima popolare sprigionata nei crocevia di
passaggio, angoli animati dalla vita vera dei suoi
abitanti, intento come un cronista a raccogliere e
raccontare attimi cristallizzati senza alcuna
pretesa di giudizio. E allora, ecco un angolo di via
Manzoni, ben lontana dal glamour del Quadrilatero
odierno, ma altresì popolato da chioschi
animatissimi; ecco una folla di avventori
familiarmente seduti ai tavoli del bar Motta sulla
soglia di una Galleria appena abbozzata, ecco le
popolarissime via Galvani e piazza Oberdan con le
edicole dei librai, ed ecco Porta Nuova già
cinquant’anni fa intruppata dai cantieri urbani.
Lo stile? Nel caso di Crippa, sarebbe un errore
critico oltre che intellettuale definirlo retrò,
ancora aggrappato alla vedutistica di inizio secolo,
quel “Novecento urbano” sviscerato dai francesi
Pissarro e Utrillo così come dagli italiani
De Pisis e Bazzaro; sarebbe un errore, come fu
quello di catalogare a rango di “fumettoni” le
piazze fantasmagoriche del grande Dino Buzzati; che
una volta pubblicamente protestò con quei critici
che ne snobbavano la pittura e ironizzavano sui
«cromatismi elementari». La Storia diede ragione al
maestro.
Da un certo punto di vista, quella di Crippa va
vissuta come una narrazione pittorica che ha sempre
(forse volutamente) viaggiato su un binario
parallelo a quello della ricerca avanguardistica,
con un linguaggio al guado tra pittura, cronaca e un
fraseggio poetico che fotografa l’attimo fuggente,
con un velo di nostalgia verso l’anima più intima e
nascosta di una città che ha sempre amato – forse
troppo – guardare avanti e guardarsi fuori; quella
Milano, scriveva Alda Merini: “dai
vorticosi pensieri, dove le mille allegrie muoiono
piangenti sul Naviglio”.